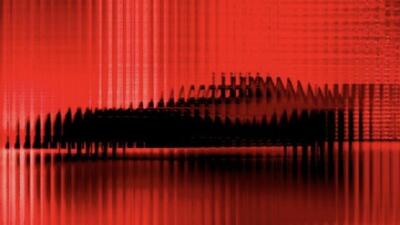Lele Sacchi, il “professore” della consolle

Scrive libri ed ha fatto anche il professore di storia (della musica, of course). E' un grande studioso, ma è anche uno dei DJ più influenti della scena italiana, oltre ad essere produttore e conduttore sia in TV che in radio. E' Gabriele “Lele” Sacchi, classe 1975 ed un'adolescenza da “skater punk” con un passione per la musica che si è trasformata negli anni nella sua professione.
Lele Sacchi è l'ospite di Luca Bordoni in questa puntata di The Music Driver, il format di Automoto.it in collaborazione con Jeep. La destinazione è l'Apollo Club di Milano, che Lele e Luca raggiungono a bordo della versatile Jeep Renegade, la Jeep best seller in Europa proposta con motori benzina 3 cilindri 1.0 da 120 CV e 4 cilindri 1.3 da 150 o 180 CV a prezzi di listino che variano da 21.390 a 34.500 euro.
Naviga su Automoto.it senza pubblicità
Non sei un DJ “normale”. Hai scritto anche un libro. Ce lo descrivi? «Si, ho scritto un libro che si chiama Club Confidential che non è legato esclusivamente alla musica, ma che contiene anche una serie di ragionamenti sui rapporti ad esempio tra politica e clubbing o tra droga e clubbing. C'è anche un capitolo dedicato al fisico del DJ, cioè su come questo lavoro abbia dei risvolti sul corpo abbastanza importanti, come ad esempio le conseguenze del dormire poco. Parlo anche di qualche aneddoto personale, come di quando avevo 12, 13, 14 anni ed ero uno “skater punk” a Pavia ed ascoltavo hardcore punk anni '80».
Differenze tra ieri e oggi nel tuo mestiere? «Quando c'erano i vinili dovevi prepararti le borse, i flight case, che avevano uno spazio limitato ed inevitabilmente avevi anche un numero limitato di canzoni che potevi suonare nel weekend. Era un limite che però stimolava molto l'immaginazione: se finivi di aver suonato tutto quello che avevi in testa andavi a cercare un lato B che magari avevi sentito una volta sola e provavi a capire se andava bene. In realtà il digitale aiuta in tanti aspetti: sembra quasi di fare un remix dal vivo, perché magari puoi mettere in loop solo una parte di batteria, ad esempio. A me piace tantissimo avere tanti giga di musica e utilizzarla quando penso che ci sta bene. E' una grande opportunità».

Il fatto che sia cambiata la tecnologia non implica forse che oggi serve meno cultura musicale rispetto a prima? «Se parliamo solo di DJ purtroppo sì, nel senso che il lavoro di ricerca che bisognava fare quando c'erano solo i vinili portava inevitabilmente a dover studiare, a doversi fare una cultura frequentando i negozi di dischi. Adesso se vogliamo c'è più “democraticità”, è anche molto meno costoso: un file in qualità alta costa 1 o 2 euro, quindi teoricamente uno che ha voglia ha la possibilità di “studiare” ancora di più. Però tutta questa offerta non sembra creare la voglia di fare dei collegamenti tra un periodo storico e l'altro, fra un produttore e un altro. Sembra quasi che questo mondo porti i ragazzi a cliccare solo su quello che compare loro sullo schermo».
Ci sono ancora le grandi hit? Quelle che ti facevano identificare un periodo con un brano? «No, non ci sono più. Le ultime risalgono a metà degli anni 2000, massimo fino al 2008. Ci sono dei tormentoni estivi, diciamolo anche... un po' di merda. Ad esempio “Give it away” dei Red Hot Chili Peppers che è durata più di tre anni e non una sola stagione. Forse le ultime le ha fatte fare Williams, come “Happy”, che comunque erano molto molto molto pop, cioè che piacevano dai bambini alla nonna. Perché? Boh, forse c'è troppa musica ed il consumo è veramente molto veloce. Poi c'è la questione della crisi dell'industria discografica dovuta al fatto che non si vendano più molti supporti fisici e che tutto sia andato sullo streaming, che ha sì dato la musica a tutti, però ha tolto il filtro della saggezza e della competenza delle persone che lavoravano nelle etichette discografiche. Il lavoro di team è importante: mediamente l'artista tende a rincorrere idee proprie che a volte sono geniali, però per costruire un pacchetto ben fatto serve il lavoro di molti».

Come si crea un brano di successo? «Essendo cambiata la fruizione è cambiato anche il modo di scrivere, è cambiato anche chi scrive. E' molto difficile adesso farci dei soldi. Il 90% dei gruppi se ne “sbatte” e fa quello che gli pare, seguendo solo la propria vena artistica. Ma solo il 10% ha successo facendo della musica “diversa”».
Cos'è l'auto per un DJ? «I grandi negli anni '90, come Claudio Coccoluto o Ralf, facevano non so quanti chilometri in un anno perché dopo la serata c'erano anche gli after hours e quindi in un weekend si facevano anche 4-5 serate. Magari si passava da Padova a Rovigo per poi partire verso Frosinone. In auto si passava davvero un sacco di tempo».
Il DJ secondo te è un musicista? «E' un artigiano, una parola che ho usato spesso per descrivere il mio mestiere. L'artigiano è infatti una sorta di artista, che non usa una tela vuota ma utilizza degli attrezzi su del materiale già pronto, che combina, incastra, modifica per farlo diventare qualcos'altro. In questo il DJ è molto simile a un artigiano».